© diritti riservati.
Le immagini e i testi sono coperti da copyright; ne è vietata la duplicazione anche parziale e l'utilizzo a fini commerciali senza l'espressa autorizzazione dell'autore.
vai alla photo gallery
Molto prima che l’intensa campagna di scavi succedutisi dalla metà del novecento in poi, ne mettesse alla luce tutto lo splendore del sito, Richard Craven scrisse: -“Dietro Avezzano c’è un masso montagnoso ben delineato e distaccato, ombreggiato da alberi e ricco di coltivazioni, su cui è il paesino di Alba, che rappresenta l’antica Alba Fucensis; le sue rovine si vedono a grande distanza, sotto le due cime logorate dalle intemperie e ombrose del monte Velino (…)”-.
Ancora oggi è un’emozione forte quella che si prova scendendo dalla collina, lasciandosi alle spalle la graziosa chiesa romanica di San Pietro, per dirigersi verso la valletta ove sorgeva un tempo il cuore urbano di Alba Fucense, già insediamento italico, poi colonia romana tra le più importanti del territorio. All’apice del suo splendore, in epoca repubblicana, fu rinomata stazione di villeggiatura per ricchi patrizi e luogo di prigionia di re e condottieri in epoca imperiale.
-“Situata sotto le cime gemelle del Monte Velino che, ai nostri occhi, cambiano colore dal blu, al tortora e all’opale”- scrive Anne Mcdonnel che nel 1914, con la sua amica pittrice Amy Atkinson, compie un lungo viaggio in Abruzzo, -“posta in un luogo scosceso, Alba domina tutta la campagna circostante e la pianura dove un tempo c’era il lago del Fucino, le cui acque anticamente raggiungevano quasi le rocce ove essa poggia. Tutt’intorno, disposte in circolo perfetto, vi sono grandi montagne ed appena ci sediamo queste si oscurano perché dal nord si leva un vento freddo (…)”-.
 Situata al limitare del territorio dei Marsi, eletta dai romani a colonia nel
303 a.c., Alba sorgeva lungo la Via Valeria, all’intersezione di una importante
rete viaria e in posizione dominante, quindi strategica dal punto di vista
militare. Da sempre nelle grazie di Roma, godette di particolari privilegi al
punto da essere eletta anzitempo a municipium e a sede di Senato. Nel suo
massimo splendore, che durò fino in epoca imperiale, raggiunse i 50.000
abitanti, potendo vantare perfino il conio di una sua moneta in argento. Lo
splendore candido dei suoi ricchi edifici coperti di marmi, stagliati tra
oliveti e macchie di agrumi, le valse il nome di Alba, la bianca, la perla del
lago. Alfred Steinitzer ne è estasiato: -“Qui il panorama è davvero incomparabile.
Il quadro è dominato dal possente Velino che emerge quasi improvvisamente dalla
pianura. Soltanto basse alture circondano i suoi piedi e su di esse si spiegano
flessuose le città marse (…). Lo sguardo vaga oltre il bacino dell’antico lago
Fucino e resta fisso sull’ampia corona delle cime selvagge d’abruzzo.”-.
Situata al limitare del territorio dei Marsi, eletta dai romani a colonia nel
303 a.c., Alba sorgeva lungo la Via Valeria, all’intersezione di una importante
rete viaria e in posizione dominante, quindi strategica dal punto di vista
militare. Da sempre nelle grazie di Roma, godette di particolari privilegi al
punto da essere eletta anzitempo a municipium e a sede di Senato. Nel suo
massimo splendore, che durò fino in epoca imperiale, raggiunse i 50.000
abitanti, potendo vantare perfino il conio di una sua moneta in argento. Lo
splendore candido dei suoi ricchi edifici coperti di marmi, stagliati tra
oliveti e macchie di agrumi, le valse il nome di Alba, la bianca, la perla del
lago. Alfred Steinitzer ne è estasiato: -“Qui il panorama è davvero incomparabile.
Il quadro è dominato dal possente Velino che emerge quasi improvvisamente dalla
pianura. Soltanto basse alture circondano i suoi piedi e su di esse si spiegano
flessuose le città marse (…). Lo sguardo vaga oltre il bacino dell’antico lago
Fucino e resta fisso sull’ampia corona delle cime selvagge d’abruzzo.”-.
Ma c’è anche qualcosa di sinistro nel ricordo di Alba; ai tempi della massima potenza, quando le sue mura di cinta si ergevano alte e terribili, nascondevano all’interno oscure tragedie. Infatti durante le guerre puniche divenne carcere di stato in cui vennero ridotti in catene personaggi importanti come Sìface re di Numidia e Perseo sovrano di Macedonia. Nella cronaca storica di quella che fu all’epoca opulenta cittadina, si ritrovano molte tracce delle vicende della Roma antica, come l’odio tremendo tra Mario e Silla, la contesa tra Cesare e Pompeo, la lotta fratricida tra Marco Antonio e Ottaviano e così via, fino al periodo dei fasti imperiali, al prosciugamento del lago, all’inizio della sua decadenza e all’abbandono, intorno al terzo secolo dopo cristo, nel periodo delle invasioni barbariche. Dopodichè –“La povera Alba, demolita e simile a un re morto, era adatta ad essere depredata.”- riflette la Mcdonnel, -“Dopo che fu saccheggiata e messa a ferro e fuoco da Goti e Saraceni, era ancora rimasto abbastanza della sua antica grandezza da attirare gli avidi (…)”-.
![]() Alba Fucens è il centro più noto del territorio
un tempo appartenuto agli Equi, il cui nome oggi si identifica con quello del
paese di Massa d'Albe, nei pressi di Avezzano. La città venne fondata come colonia
latina nel 303 a.C. non lontano dal Lago Fùcino, in un punto in cui la via
Valeria incrociava un antico percorso che dall'Etruria conduceva sino in
Campania. Durante la "guerra sociale" Alba Fucens, che si mantenne fedele
a Roma, fu al centro degli scontri e nelle cronache dei maggiori storici e
cronisti dell'epoca.
Alba Fucens è il centro più noto del territorio
un tempo appartenuto agli Equi, il cui nome oggi si identifica con quello del
paese di Massa d'Albe, nei pressi di Avezzano. La città venne fondata come colonia
latina nel 303 a.C. non lontano dal Lago Fùcino, in un punto in cui la via
Valeria incrociava un antico percorso che dall'Etruria conduceva sino in
Campania. Durante la "guerra sociale" Alba Fucens, che si mantenne fedele
a Roma, fu al centro degli scontri e nelle cronache dei maggiori storici e
cronisti dell'epoca.
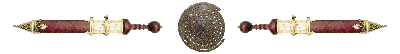
Note sull'impianto urbanistico e monumentale della città.
Tratto dall'opera "Alba Prope Fucinum Lacum",
della Dott. Roberta Cairoli,
per gentile concessione.
"(...)Tutte le vie principali, secondo il metodo costruttivo romano, si presentano lastricate da basole poligonali e con profilo lievemente convesso per meglio fare defluire le acque piovane verso i lati della strada. Spesso recano ancora le tracce dei carri, che transitavano in epoca romana in città. Inoltre, in mezzo alle strade venivano collocati, ad una quota superiore, tre blocchi dagli angoli arrotondati, posti a poca distanza l'uno dall'altro; ciò permetteva sia di costringere i carri a rallentare la loro andatura, sia di attraversare la strada in caso di allagamenti dovuti a piogge torrentizie."
![]() Via dei
Pilastri. "Parallelo al
decumanus maximus, posto subito ad ovest del Foro, della Basilica, delle Terme e
del cosiddetto Santuario di Ercole, è l'asse stradale denominato via dei
Pilastri, largo circa m. 4.30 e fiancheggiato da marciapiedi di circa cm. 30/40
di altezza. Alcuni paracarri presentano dei fori per il fermo delle redini dei
cavalli in caso di sosta. Questo asse viario partiva dall'ingresso della grande
terrazza nord e scendeva verso sud fiancheggiando ad est il Comizio, il Foro, la
Basilica, le terme, il Santuario di Ercole e separando tale settore dalle
botteghe e dal Teatro."
Via dei
Pilastri. "Parallelo al
decumanus maximus, posto subito ad ovest del Foro, della Basilica, delle Terme e
del cosiddetto Santuario di Ercole, è l'asse stradale denominato via dei
Pilastri, largo circa m. 4.30 e fiancheggiato da marciapiedi di circa cm. 30/40
di altezza. Alcuni paracarri presentano dei fori per il fermo delle redini dei
cavalli in caso di sosta. Questo asse viario partiva dall'ingresso della grande
terrazza nord e scendeva verso sud fiancheggiando ad est il Comizio, il Foro, la
Basilica, le terme, il Santuario di Ercole e separando tale settore dalle
botteghe e dal Teatro."
![]() "Il
cardo maximus,
dai primi ricercatori, fu denominato
via dell'Elefante
poiché vi rinvennero un sedile in marmo decorato da protomi di elefanti; la via
separa l'edificio della Basilica dal Foro per risalire in direzione di Porta di
Massa collegando così tutti i decumani. Attualmente, questa strada, proseguendo
verso ovest, taglia la cinta muraria."
"Il
cardo maximus,
dai primi ricercatori, fu denominato
via dell'Elefante
poiché vi rinvennero un sedile in marmo decorato da protomi di elefanti; la via
separa l'edificio della Basilica dal Foro per risalire in direzione di Porta di
Massa collegando così tutti i decumani. Attualmente, questa strada, proseguendo
verso ovest, taglia la cinta muraria."
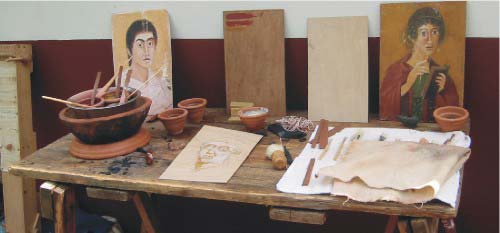
![]() "Le
botteghe private si
snodavano lungo i decumani di via dei Pilastri e via del Miliario, prospicienti
agli edifici pubblici. Lungo via dei Pilastri l'isolato delle tabernae era
sostenuto da uno dei muri di terrazzamento in opera poligonale che tagliano la
valletta interna della città; la serie delle diciotto botteghe sinora messe in
luce era preceduta da un porticato largo m. 2.35 sorretto da pilastri squadrati
coronati da capitelli rettangolari (attualmente se ne conservano tre); disposti
a distanze regolari e in corrispondenza delle murature portanti delle tabernae,
raggiungevano un'altezza di circa m. 5. I pilastri del portico dovevano
sorreggere il piano superiore delle botteghe, probabilmente adibito ad
abitazione privata.
"Le
botteghe private si
snodavano lungo i decumani di via dei Pilastri e via del Miliario, prospicienti
agli edifici pubblici. Lungo via dei Pilastri l'isolato delle tabernae era
sostenuto da uno dei muri di terrazzamento in opera poligonale che tagliano la
valletta interna della città; la serie delle diciotto botteghe sinora messe in
luce era preceduta da un porticato largo m. 2.35 sorretto da pilastri squadrati
coronati da capitelli rettangolari (attualmente se ne conservano tre); disposti
a distanze regolari e in corrispondenza delle murature portanti delle tabernae,
raggiungevano un'altezza di circa m. 5. I pilastri del portico dovevano
sorreggere il piano superiore delle botteghe, probabilmente adibito ad
abitazione privata.
La ripartizione primaria delle botteghe prevedeva che ogni singola unità
raggiungesse le dimensioni di M. 5/5.50 di larghezza per una lunghezza di m.
9/12. Una divisione interna prevedeva anche l'esistenza di un retrobottega. La
seconda taberna a partire dall'incrocio fra via dell'Elefante e via dei Pilastri
era destinata a thermopolium, dove si vendevano bevande e vino caldo. Un bancone
rivestito di crustae marmorae di colore rosa separava l'esercente dai clienti ed
una vaschetta, posta sul bancone stesso, serviva presumibilmente per la mescita
delle bevande. Alla base del bancone si conserva un tombino in pietra collegato
con un condotto sottostante.
In alcune botteghe si vedono ancora grossi contenitori di ceramica incassati nel
pavimento, da cui si potevano attingere, per mezzo di orci o attingitoi, olio,
latte, vino, ecc. Tutta la serie di botteghe era preceduta da soglie in pietra
con scanalature per lo scorrimento di pannelli mobili, bloccati agli stipiti da
una sbarra al momento della chiusura dei locali."
![]() Il
Teatro.
"Questo edificio da
spettacolo, ricavato nel substrato roccioso del colle Pettorino, si apre verso
sud-ovest su di una
Il
Teatro.
"Questo edificio da
spettacolo, ricavato nel substrato roccioso del colle Pettorino, si apre verso
sud-ovest su di una vasta terrazza, secondo un modello di derivazione
ellenistica. Quasi completamente espoliato già in antico, conserva poderose
strutture di sostenimento della cavea (analemnata), i corridoi di ingresso (parodoi)
e le sostruzioni della scena. La facciata, che raggiunge una lunghezza di m. 77,
è realizzata in opera poligonale usata come paramento di un nucleo cementizio e
coronata in alzato dall'opera reticolata, mentre le testate d'angolo sono
concepite come ammorsature in opera quadrata.
vasta terrazza, secondo un modello di derivazione
ellenistica. Quasi completamente espoliato già in antico, conserva poderose
strutture di sostenimento della cavea (analemnata), i corridoi di ingresso (parodoi)
e le sostruzioni della scena. La facciata, che raggiunge una lunghezza di m. 77,
è realizzata in opera poligonale usata come paramento di un nucleo cementizio e
coronata in alzato dall'opera reticolata, mentre le testate d'angolo sono
concepite come ammorsature in opera quadrata.
Dall'analisi della tecnica edilizia e dai segni di giunture nella muratura, si
può ritenere che gli analemnata siano stati oggetto di restauro: ad una prima
fase ascrivibile alla fine del Il sec. a. C. deve essere succeduta una fase di
ampliamento da collocarsi alla metà del I sec. a. C. e che vide l'adozione
dell'opera reticolata per ampliare gli analemnata e la cavea. Il corridoio
d'accesso settentrionale, è collegato tramite una scala di sette gradini ad un
vicolo in pendenza che si riconnette ortogonalmente a via dei Pilastri
(all'altezza della vasca-fontana). La cavea conserva ancora le gradinate,
realizzate nella roccia stessa, tagliata e lisciata. Inserita al centro della
cavea è l'orchestra (sede, nel teatro romano, dei sedili dei personaggi di
riguardo dell'aristocrazia cittadina), del diametro di m. 10 circa e
originariamente pavimentata con lastre rettangolari di pietra calcarea,
conservate ora in numero esiguo; una scanalatura corre lungo il bordo e segna il
limite dalla cavea.
Di fronte l'orchestra è il complesso della scaena (il palco), un edificio di
forma rettangolare di mt. 12x42.50, ripartito nella sua lunghezza in due
settori: il proscaenium, aperto verso il pubblico, dove recitavano gli attori, e
il pulpitum, diviso in sette ambienti da tramezzi in opera reticolata per
alloggiarvi la frons scaenae, ovvero l'apparato scenografico, evidentemente
realizzato con pannelli mobili probabilmente in legno in modo da potere essere
montati e smontati in obbedienza alle esigenze sceniche. Fra la scena e
l'orchestra, a livello pavimentale, erano ricavati dei pozzetti (cm. 36x40)
posti a distanze regolari, coperti da lastre di pietra forate, che raggiungevano
una profondità di m. 2.66; essi dovevano sicuramente servire ad alloggiare e
sostenere i macchinari per la manovra dell'aulaeum (sipario), che nell'antichità
veniva sollevato dal basso verso l'alto."
"...la cosiddetta Venere di Alba, rinvenuta in una delle tabemae di via dei
Pilastri, è ora al Museo Nazionale di Chieti. L'opera, di età augustea,
raggiunge un'altezza di soli cm. 80 ed è una raffinata riproduzione scultorea di
una famosissima opera dei pittore Apelle, autore di un quadro che rappresentava
Afrodite Anadiomene, ovvero Venere nuda, nata dal mare, rappresentata nell'atto
di raccogliersi i capelli. La riproduzione marmorea è realizzata in due blocchi
uniti da un perno in ferro collocato al centro del corpo; la statua, che
raffigura la dea cinta ai fianchi da un ampio panneggio che scende sino ai
calzari, è purtroppo mancante della testa, del braccio destro, della mano
sinistra e del nodo che legava il panneggio.
![]() Santuario
di Ercole. E' una grande
piazza (m. 84x37 circa), di forma rettangolare, circondata da portici sostenuti
da due serie di colonne, risalente al secondo quarto del I sec. a.C.. I lati
lunghi impostano su tratti murari in opera poligonale, gli originari muri, che
sostruivano longitudinalmente i terrazzamenti della città. In particolare questi
muri, speculari fra loro, sono quelli posti alla quota più bassa del Piano di
Civita. Il pavimento del portico è in lastre di calcare rettangolari,
delimitate, verso l'area interna aperta della piazza, da canalette in pietra per
la raccolta delle acque piovane provenienti dalla copertura.
Santuario
di Ercole. E' una grande
piazza (m. 84x37 circa), di forma rettangolare, circondata da portici sostenuti
da due serie di colonne, risalente al secondo quarto del I sec. a.C.. I lati
lunghi impostano su tratti murari in opera poligonale, gli originari muri, che
sostruivano longitudinalmente i terrazzamenti della città. In particolare questi
muri, speculari fra loro, sono quelli posti alla quota più bassa del Piano di
Civita. Il pavimento del portico è in lastre di calcare rettangolari,
delimitate, verso l'area interna aperta della piazza, da canalette in pietra per
la raccolta delle acque piovane provenienti dalla copertura.
A centro della piazza, verso settentrione, si conservano i resti di un altare di
forma rettangolare. Nel lato settentrionale, inserito nel complesso delle terme,
è un piccolo sacello di m. 14.50x5, pavimentato con mosaico bianco a fascia
periferica nera. Verso l'ingresso è un'iscrizione su mosaico con il nome del
donatore dell'edificio, Lucio Vettio, figlio di Quinto. Il pavimento risale alla
costruzione del sacello, ovvero ad epoca sillana, mentre le pareti furono
intonacate in epoca giulio-claudia. In fondo alla cella era un'edicola preceduta
da una soglia di passaggio in mosaico, decorata con il motivo del meandro; in
essa trovava posto un baldacchino su colonne di laterizi stuccate, che sosteneva
la statua di Ercole seduto a banchetto (originariamente su un seggio in
materiale deperibile), rinvenuta in frammenti.
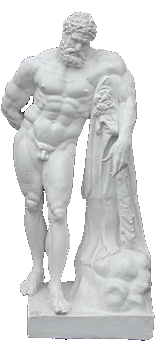 Immediatamente a nord è collocato il complesso delle terme, che risale, nel suo
primo impianto, alla metà del I sec. a.C. Evidentemente la piazza in analisi
doveva essere in un primo tempo strutturalmente e funzionalmente collegata al
complesso termale, con il quale si raccordava mediante gli ingressi poi richiusi
e anche i piani pavimentali dei rispettivi edifici dovevano essere in quota.
Solo in una fase più tarda gli ambienti di comunicazione con la piazza vennero
chiusi, colmati da un cospicuo reinterro e attribuiti esclusivamente alle terme.
Sulla destinazione d'uso dell'edificio sono state formulate alcune ipotesi, ma
generalmente la più accettata identifica l'area come un grande mercato e il
sacello dedicato ad Ercole perché garante e intermediario degli scambi
commerciali. Il mercato è stato proposto come forum pecuarium, per la
compravendita degli ovini: l'ingresso a scivolo e la posizione dell'edificio,
presso la Porta Sud, sono adatti al passaggio del gregge.
Immediatamente a nord è collocato il complesso delle terme, che risale, nel suo
primo impianto, alla metà del I sec. a.C. Evidentemente la piazza in analisi
doveva essere in un primo tempo strutturalmente e funzionalmente collegata al
complesso termale, con il quale si raccordava mediante gli ingressi poi richiusi
e anche i piani pavimentali dei rispettivi edifici dovevano essere in quota.
Solo in una fase più tarda gli ambienti di comunicazione con la piazza vennero
chiusi, colmati da un cospicuo reinterro e attribuiti esclusivamente alle terme.
Sulla destinazione d'uso dell'edificio sono state formulate alcune ipotesi, ma
generalmente la più accettata identifica l'area come un grande mercato e il
sacello dedicato ad Ercole perché garante e intermediario degli scambi
commerciali. Il mercato è stato proposto come forum pecuarium, per la
compravendita degli ovini: l'ingresso a scivolo e la posizione dell'edificio,
presso la Porta Sud, sono adatti al passaggio del gregge.
Il dio era anche considerato protettore dei pastori e degli armenti. Inoltre,
un'iscrizione albense (CIL IX 3961) ricorda la corporazione di cultores Herculis
Sala(rii) ossia di sacerdoti del culto di Ercole quale protettore del commercio
del sale, integratore indispensabile nel l'alimentazione delle pecore e delle
capre. Un dato importante proviene dagli scavi che vennero effettuati in
profondità e che rilevarono l'esistenza di un spazio sacro dedicato ad Ercole,
sin dal III sec. a.C.; se così fosse possiamo avanzare l'ipotesi che un forum
Pecuarium preesistesse la deduzione della colonia, magari collocato fuori le
mura del primitivo insediamento equo e perfettamente inserito in un circuito di
scambi commerciali consolidato già da tempo.
La statua marmorea ritrovata in loco rappresenta proprio la colossale
statua dell'Ercole a banchetto (Herakles Epitrapezios) rinvenuta dentro il
sacello e ora esposta nel Museo Nazionale di Chieti. La statua era addossata al
muro di fondo, nell'edicola del sacello, in posizione frontale. Fonti storiche
tramandano dell'esistenza di una statua in bronzo di Ercole a banchetto, di
piccole dimensioni, realizzata da Lisippo. Per quanto attiene l'Ercole di Alba,
ancora è incerto se essa sia una copia di grandi dimensioni dell'originale
lisippeo, una copia di un'originale di siffatte proporzioni, opera dello stesso
autore, di cui ignoriamo l'esistenza, oppure una realizzazione ad hoc per il
sacello dei santuario albense."
![]() "Il
decumanus maximus
è stato riconosciuto nella strada che fiancheggia verso occidente il Foro, la
Basilica, il macellum, le terme, per uscire, con una leggera deviazione,
direttamente da Porta Sud. Questa strada, larga fra i m. 3.67 ed i m. 4.34, è
fiancheggiata da marciapiedi di cm. 30/40 di altezza; l'attuale denominazione di
via del Miliario la si deve al rinvenimento di un cippo miliare, che ha
consentito di riconoscere in questo asse stradale il diverticolo della via
Valeria, che entrava da Porta Massima. Ancora oggi si legge:
"Il
decumanus maximus
è stato riconosciuto nella strada che fiancheggia verso occidente il Foro, la
Basilica, il macellum, le terme, per uscire, con una leggera deviazione,
direttamente da Porta Sud. Questa strada, larga fra i m. 3.67 ed i m. 4.34, è
fiancheggiata da marciapiedi di cm. 30/40 di altezza; l'attuale denominazione di
via del Miliario la si deve al rinvenimento di un cippo miliare, che ha
consentito di riconoscere in questo asse stradale il diverticolo della via
Valeria, che entrava da Porta Massima. Ancora oggi si legge:
LXVIII / LIBERATORI ORBIS ROMANI RESTITVTORI LIBERTATI / ET REI PVBLICE
CONSERVATORI MILITVM ET PROVINCIALIVM / DOMINI NOSTRI MAGNENTIO INVICTO PRINCIPI
VICTORI AC-TRIVMPHATORI SEMPER AVGUSTO FLAVIVS ROMANVS VIR CLARISSIMVS /
CONSVLARIS FLAMINIAE ET PICENI CVRAVIT = 68° miglio.
Al liberatore del mondo romano, restauratore della libertà e conservatore dello
Stato, dei soldati e delle provincie, nostro signore Magnenzio, principe
invitto, vincitore e trionfatore, sempre augusto.
Il cippo è evidentemente di riutilizzo, con un'iscrizione precedente cancellata
ed una raffigurazione di due gladiatori nell'atto di combattere. Il nome
dell'imperatore Magnenzio, invece, appare martellato e ciò si spiega con il
provvedimento di damnatio memoriae che lo colpì dopo la sua morte; tale
provvedimento comportava la cancellazione del nome da tutti i monumenti pubblici
e la distruzione di ogni immagine statuaria o di monumenti in onore.
La via del Miliario serviva sul suo lato orientale i principali edifici pubblici
della colonia. A partire da nord, era il Comitium (oggi ricoperto), ovvero
l'edificio dove avevano luogo le assemblee politiche della città. La pianta
dell'edificio prevedeva un'area circolare interna, del diametro di m. 17,
circondata da una breve gradinata dove ascoltavano in piedi coloro che
partecipavano alle riunioni.
La corte era inscritta in un edificio a pianta quadrata fiancheggiato da due ali
lunghe. L'entrata si apriva verso la piazza del Foro, posta immediatamente più a
sud. La derivazione magno-greca della tipologia monumentale permette di fare
risalire il complesso entro l'ambito del 111 sec. a.C., epoca nella quale fu
costruito anche il Foro.
Le dimensioni e la forma estremamente allungata (m. 172.68x43.50) sono tipici
dei fori più antichi che si conoscono e il nostro può ben riferirsi agli anni
immediatamente successivi la deduzione della colonia. Collegato con il Foro e
posizionato lungo il lato breve meridionale della piazza è un porticato
rettangolare, del quale si conservano solo le basi, che appare come una
sistemazione architettonica di età tardo-repubblicana. Precedentemente, il
porticato era stato preceduto da una serie di pozzetti risalenti perlomeno a due
momenti storici distinti e interpretabili come pozzi di consacrazione del Foro
(considerato come un tempio), ma anche come fondazioni di strutture mobili
utilizzate durante le votazioni elettorali.
Procedendo verso sud, via del Miliario fiancheggia la Basilica, il luogo
convenuto per l'amministrazione della giustizia, ma poteva servire a qualsiasi
riunione al coperto, ad esempio, per i mercanti o per i finanzieri che facevano
operazioni di borsa. La pianta, di derivazione ellenistica, riproduce il modello
delle più antiche basiliche, aventi uno dei lati lunghi rivolti verso il Foro.
E' di forma rettangolare, di m. 53.10x23.35, e realizzata in opera incerta con
rinforzi angolari in opera quadrata. La costruzione, di epoca post-sillana,
segui una precedente destinazione d'uso dell'area, che, negli anni successivi
alla fondazione della città, era invece occupata da abitazioni private.
![]() Terme.
A sud del macellum era il complesso dei bagni pubblici. Il bagno nelle terme
pubbliche era una delle pratiche più diffuse nella società romana. Lo schema
principale nell'articolazione dei vani era il seguente: la piscina scoperta (natatio);
la sala con vasche per il bagno freddo, di solito piccola e alta, (frigidarium);
un ambiente più piccolo con bacini per le abluzioni per il bagno tiepido (tepidarium)
e di passaggio con il calidarium, la sala più luminosa con vasche per il bagno
caldo. L'acqua per i bagni caldi era riscaldata attraverso un sistema di forni a
legna e caldaie da cui si dipartivano le tubazioni: dal forno, l'aria calda
passava in un cunicolo che la convogliava sotto i pavimenti delle sale da
riscaldare sostenuti da pilastrini in mattoni (sospensurae), alti circa 60 cm..
Terme.
A sud del macellum era il complesso dei bagni pubblici. Il bagno nelle terme
pubbliche era una delle pratiche più diffuse nella società romana. Lo schema
principale nell'articolazione dei vani era il seguente: la piscina scoperta (natatio);
la sala con vasche per il bagno freddo, di solito piccola e alta, (frigidarium);
un ambiente più piccolo con bacini per le abluzioni per il bagno tiepido (tepidarium)
e di passaggio con il calidarium, la sala più luminosa con vasche per il bagno
caldo. L'acqua per i bagni caldi era riscaldata attraverso un sistema di forni a
legna e caldaie da cui si dipartivano le tubazioni: dal forno, l'aria calda
passava in un cunicolo che la convogliava sotto i pavimenti delle sale da
riscaldare sostenuti da pilastrini in mattoni (sospensurae), alti circa 60 cm..

Di servizio a questi principali ambienti erano una serie di sale e vani dalle
differenti destinazioni: lo spogliatoio con panche di pietra ricavate nel
perimetro della stanza (l'apodyterium); un piccolo ambiente molto riscaldato per
saune e bagni turchi (laconicum); sale per massaggi e depilazioni, palestre per
la ginnastica (sphaeristerium), sale per l'unzione del corpo o per pulirsi dalla
polvere delle palestre (destrictoria e unctoria), sale di lettura ed, infine,
sale ristoro (popinae). Delle terme di Alba Fucens si riconoscono alcuni
ambienti adibiti sicuramente a calidaria. Il primo è collocato fra il Macellum e
via dei Pilastri e doveva appartenere al nucleo più antico dell'edificio
termale, poiché i pavimenti poggiano su costruzioni più antiche.
Fra questo ambiente e la piazza porticata di Ercole è situata una piscina con
due scalette per scendere. Altre sale riscaldate sono visibili nel settore che
confina con via del Miliario, mentre i bagni pubblici (latrinae) sono collocati
nei pressi del santuario di Ercole: si tratta di due ambienti, uno per gli
uomini e uno per le donne, in cui ancora si conservano le panche ed i sedili in
pietra in corrispondenza dei quali è un sistema di condotti e canalette per la
raccolta e l'allontanamento delle acque nere. Uno degli accessi alle terme è
riconoscibile lungo via del Miliario: l'ingresso è pavimentato con mosaico
bianco e un'iscrizione ricorda che i bagni, costruiti probabilmente durante la
prima metà del 1 sec. a.C., furono restaurati per volontà di una donna di nome
Vibia Galla (Vibia Cai Filia Galla balneum-de suapecunia reficiendum curavit).
Per alcuni si tratterebbe di una figlia dell'imperatore Gaio Vibio Treboniano
Gallo (251-253 d.C.), che ebbe rapporti con Alba Fucens documentati anche in
un'altra iscrizione.
![]() "Il più
importante mercato al dettaglio sinora individuato ad Alba Fucens è
rappresentato dal Macellum; tale edificio, collocato fra la Basilica e le Terme,
riuniva botteghe che non solo vendevano carne, ma anche ogni genere di
commestibile, compreso il pesce (a Pompei, al di sotto del macellum si sono
rinvenute numerose lische di pesce). L'edificio ha conosciuto, nel corso dei
secoli, varie fasi di ristrutturazione, alcune anche sostanziali. In una prima
fase, ascrivibile agli inizi del I sec. a.C., una stradina secondaria,
pavimentata con lastre di pietra calcarea, collegava via del Miliario con via
dei Pilastri. Sulla strada si apriva direttamente una piazza delimitata su tre
lati da muri in opera incerta con pilastri aggettanti in opera incerta e
rinforzi angolari in opera quadrata.
"Il più
importante mercato al dettaglio sinora individuato ad Alba Fucens è
rappresentato dal Macellum; tale edificio, collocato fra la Basilica e le Terme,
riuniva botteghe che non solo vendevano carne, ma anche ogni genere di
commestibile, compreso il pesce (a Pompei, al di sotto del macellum si sono
rinvenute numerose lische di pesce). L'edificio ha conosciuto, nel corso dei
secoli, varie fasi di ristrutturazione, alcune anche sostanziali. In una prima
fase, ascrivibile agli inizi del I sec. a.C., una stradina secondaria,
pavimentata con lastre di pietra calcarea, collegava via del Miliario con via
dei Pilastri. Sulla strada si apriva direttamente una piazza delimitata su tre
lati da muri in opera incerta con pilastri aggettanti in opera incerta e
rinforzi angolari in opera quadrata.
![]() Fra gli edifici per lo spettacolo,
l'anfiteatro
occupa un'area a sud della città Perfettamente inserito nel tessuto urbanistico,
il suo orientamento è identico a quello degli assi viari e degli isolati, con
una via parallela a via del Miliario, che lo raggiunge da nord. Interamente
ricavato nella roccia, raggiunge le seguenti dimensioni: m. 96 di lunghezza e m.
79 di larghezza. L'arena interna misura m. 64x37. Dalle dimensioni si può
ipotizzare che poteva contenere un numero di spettatori pari a circa un
migliaio. Due gli ingressi che, attraversando le gradinate, permettevano
l'accesso all'arena, perfettamente in asse fra loro e coincidenti con l'asse
maggiore dell'ellissi.
Fra gli edifici per lo spettacolo,
l'anfiteatro
occupa un'area a sud della città Perfettamente inserito nel tessuto urbanistico,
il suo orientamento è identico a quello degli assi viari e degli isolati, con
una via parallela a via del Miliario, che lo raggiunge da nord. Interamente
ricavato nella roccia, raggiunge le seguenti dimensioni: m. 96 di lunghezza e m.
79 di larghezza. L'arena interna misura m. 64x37. Dalle dimensioni si può
ipotizzare che poteva contenere un numero di spettatori pari a circa un
migliaio. Due gli ingressi che, attraversando le gradinate, permettevano
l'accesso all'arena, perfettamente in asse fra loro e coincidenti con l'asse
maggiore dell'ellissi.
 L'arena,
al momento dello scavo, era perimetrata da lastre di pietra rettangolari con
lati lunghi ad arco di cerchio, collegate fra loro da grappe di ferro inserite
negli appositi incavi. Su questo bordo era incassata un balaustra realizzata con
grandi lastre monolitiche squadrate e lisciate, alte due metri e leggermente
rastremate verso l'alto (spessore alla base cm. 25, spessore alla cresta cm.
25). Al momento della messa in luce dell'anfiteatro, tali baltei conservavano
ancora tracce di intonaco rosso pompeiano. Delle gradinate restano solo pochi
blocchi lapidei (cm. 68x36 di altezza) poiché il monumento era stato già in
antico espoliato per la costruzione di edifici di epoca alto-medievale.
L'arena,
al momento dello scavo, era perimetrata da lastre di pietra rettangolari con
lati lunghi ad arco di cerchio, collegate fra loro da grappe di ferro inserite
negli appositi incavi. Su questo bordo era incassata un balaustra realizzata con
grandi lastre monolitiche squadrate e lisciate, alte due metri e leggermente
rastremate verso l'alto (spessore alla base cm. 25, spessore alla cresta cm.
25). Al momento della messa in luce dell'anfiteatro, tali baltei conservavano
ancora tracce di intonaco rosso pompeiano. Delle gradinate restano solo pochi
blocchi lapidei (cm. 68x36 di altezza) poiché il monumento era stato già in
antico espoliato per la costruzione di edifici di epoca alto-medievale.
La cavea era interrotta ad intervalli regolari da scale che permettevano
l'accesso alle gradinate superiori, mentre in numero di quattro sembrano essere
stati gli anelli di percorrenza di questo settore aperto al pubblico. Nella
parte occidentale della balaustra si apre una serie di ingressi direttamente
collegati con un cunicolo sottostante la gradinata ovest, che doveva fungere da
corridoio di servizio per il personale e gli animali utilizzati durante gli
spettacoli.
Sulla facciata interna ed esterna dell'ingresso settentrionale è stata
ricollocata un'iscrizione doppia, che illumina sull'epoca della costruzione e ci
fornisce il nome del personaggio che finanziò i lavori di costruzione
dell'anfiteatro: Q(intus) NAEVIVS Q(uinti) F(ilius) FAB(ia tribu) SVTORIVS MACRO
/ PRAEFECTVS VIGILVM PRAEFECTVS PRAETORII / TI(beri) CAESARIS AVGVSTI TESTAMENTO
DEDIT = Quinto Nevio Sutorio Macrone, figlio di Quinto, della tribù Fabia,
prefetto dei vigili, prefetto al pretorio sotto Tiberio Cesare Augusto, lasciò
in testamento (il denaro per la costruzione dell'anfirteatro).

![]() La Domus.
Ad Alba Fucens sono state messe in luce quattro domus, di cui una è attualmente
ricoperta. La Casa di via del Miliario è quella che
più si avvicina allo schema canonico delle abitazioni romane. L'ingresso si apre
sulla via, quasi di prospetto all'entrata secondaria della Piazza di Ercole;
tramite tre gradini si accede al vestibolo fiancheggiato da due celle, di qui
poi si passa all'atrio. Dall'atrio si arriva al tablinum fiancheggiato dalle due
alae; infine è il peristilio con portico sorretto da colonne in mattoni
rivestiti di stucco e sormontate da capitelli di stile ionico. Nel perimetro del
portico è ancora visibile una canaletta, che permetteva di raccogliere e
convogliare le acque piovane. Ai lati del portico si aprivano invece i vari
ambienti della casa, taluni pavimentati con mosaico bianco-nero a motivi
geometrici.
La Domus.
Ad Alba Fucens sono state messe in luce quattro domus, di cui una è attualmente
ricoperta. La Casa di via del Miliario è quella che
più si avvicina allo schema canonico delle abitazioni romane. L'ingresso si apre
sulla via, quasi di prospetto all'entrata secondaria della Piazza di Ercole;
tramite tre gradini si accede al vestibolo fiancheggiato da due celle, di qui
poi si passa all'atrio. Dall'atrio si arriva al tablinum fiancheggiato dalle due
alae; infine è il peristilio con portico sorretto da colonne in mattoni
rivestiti di stucco e sormontate da capitelli di stile ionico. Nel perimetro del
portico è ancora visibile una canaletta, che permetteva di raccogliere e
convogliare le acque piovane. Ai lati del portico si aprivano invece i vari
ambienti della casa, taluni pavimentati con mosaico bianco-nero a motivi
geometrici.
Il primo impianto della domus, a cui seguirono vari rimaneggiamenti, sembra
risalire al I sec. a.C.. Le decorazioni parietali risalirebbero invece alla metà
del I sec. d. C.; in particolare, la stanza più a nord dei peristilio conserva
ancora l'intonaco dipinto per un'altezza di circa 80 cm. e caratterizzato da un
plinto di circa cm. 20 di altezza di colore rosso pompeiano, mentre la fascia
mediana appare divisa da una serie di pannelli di varia larghezza, di colore
giallo, incorniciati da bande rosse. I pannelli includono un riquadro ulteriore
definito da due linee, l'una di colore bianco con punti sovraddipinti bianchi e
rossi e l'altra di colore rosso."
© Roberta Cairoli, diritti riservati
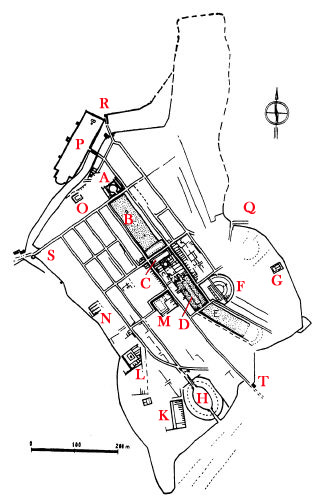
PIANTA
GENERALE DI ALBA FUCENS (elaborazione da J. Mertens).
A: Comitium; B: Forum; C: Basilica; D: Tempio di
Ercole; E: piazza del teatro; F: teatro; G: tempio sul
colle Pettoríno; H: anfiteatro; K: tempio di Apollo;
L: la Domus repubblicana; M: Domus imperiale; N: tempio 0:
criptoportico; P: terrazza nord; Q: porta di Massa; R:
porta Fellonica; S: porta Massima; T. porta Sud.
PIANTA
DEL CENTRO MONUMENTALE (Elaborazione da J. Mertens).
K: portico; L: basilica; M: macellum; N: terme;
O: taberne;
P: tempietto; Q: case repubblicane; S: casa imperiale;
T: tempio di Ercole; U: piazza del teatro; V: teatro.
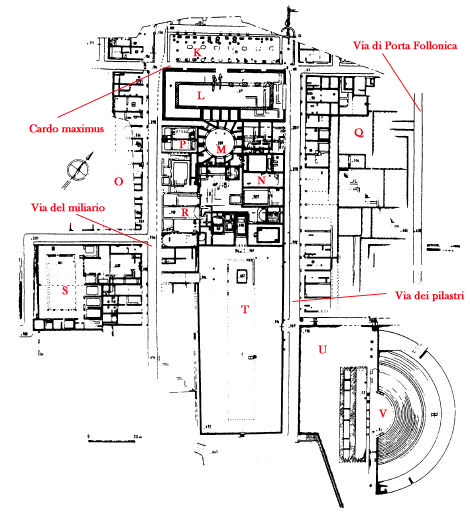
Galleria Fotografica
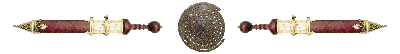
click to open